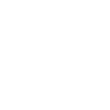Rafael Benitez mi ha fatto veramente — e salutarmente — sentire in colpa. Io non so nemmeno cosa sia il calcio: e lui si è messo a fare, molto più efficacemente di me, il lavoro che dovrei fare io. E che dovrebbero fare l’università, la scuola, i giornali: per non parlare delle soprintendenze. Che è quello di far innamorare i cittadini del loro territorio, del loro paesaggio, del loro patrimonio storico e artistico. Benitez lo ha fatto: non tanto con le sue parole, quanto con le sue azioni. È andato a visitare Pompei e la Reggia di Caserta: e fin qui poteva essere un rito sociale. Ma poi la Cappella Sansevero (col suo Cristo velato) e addirittura il Palazzo Reale (quanti napoletani non ci sono mai entrati?). E poi è stato al San Carlo, a vedere le prove della scuola di ballo, e a parlare della passione della moglie per la lirica. Benitez ha capito perfettamente ciò che noi non siamo neanche più in grado di dire. E cioè che non siamo — non siamo mai stati — italiani per diritto di sangue, ma sempre per ius soli: per l’appartenenza biunivoca che lega la nostra comunità al nostro territorio, reso unico dall’arte e dalla storia. Ancora oggi lo sperimentiamo: nella percezione del resto del mondo, gli italiani sono identificabili e ammirati, più che per ogni altra cosa, per l’altissima lingua figurativa, per la bellezza civile con la quale abbiamo saputo completare lo splendore naturale del «volto amato della Patria». Mai come oggi questo suolo unico al mondo può, e anzi deve, generare nuovi italiani: integrando nella nostra comunità chi viene a lavorare e a vivere da noi. Che si chiami Rafael Benitez, o che sia un migrante senza nome che arriva (quando ci riesce) sulla spiaggia di Lampedusa. E questo è ciò che Benitez ci ha ricordato con i suoi gesti. Poi le sue parole ci hanno ricordato anche qualcos’altro. E cioè che non siamo capaci di raccontarlo agli altri, quel patrimonio: lui veramente ha detto che non siamo capaci di venderlo. Di fare marketing. Non amo molto questa parola. Perché la quasi totalità della nostra vita è dominata dal denaro, e l’arte e la natura servono invece a rompere questo ferreo dominio. E perché quando un politico parla di «marketing del patrimonio» in genere lo fa per distruggerlo, o per vendere se stesso. E quasi sempre lo fa senza aver mai visto, frequentato, amato, ciò che dice di voler promuovere. Ma Benitez è un’altra cosa: infatti prima ha visto, e poi ha parlato. E ha detto che il patrimonio potrebbe portare lavoro. Ha ragione: potrebbe portare — aggiungo — lavoro dignitoso, e non precario. Diverso dalla schiavitù dei ragazzi che oggi generano reddito privato per i grandi concessionari che cannibalizzano il patrimonio. Il messaggio di Benitez è importante perché mette in relazione diretta due cose sempre separate: il nostro godimento del patrimonio e la capacità di aprirlo agli altri. La costituzione trecentesca di Siena diceva che la città doveva essere bella per «onore, prosperità et accrescimento dei cittadini» e poi anche per «per cagione di diletto et alegreza de’ forestieri». Ecco, la risposta migliore a Benitez non è quella di chiedergli di farci da testimonial. È ritrovare quell’amore per noi stessi e la nostra terra che è l’unica via per poterla poi aprire agli altri.

di Napoli Magazine
30/10/2013 - 19:45
Rafael Benitez mi ha fatto veramente — e salutarmente — sentire in colpa. Io non so nemmeno cosa sia il calcio: e lui si è messo a fare, molto più efficacemente di me, il lavoro che dovrei fare io. E che dovrebbero fare l’università, la scuola, i giornali: per non parlare delle soprintendenze. Che è quello di far innamorare i cittadini del loro territorio, del loro paesaggio, del loro patrimonio storico e artistico. Benitez lo ha fatto: non tanto con le sue parole, quanto con le sue azioni. È andato a visitare Pompei e la Reggia di Caserta: e fin qui poteva essere un rito sociale. Ma poi la Cappella Sansevero (col suo Cristo velato) e addirittura il Palazzo Reale (quanti napoletani non ci sono mai entrati?). E poi è stato al San Carlo, a vedere le prove della scuola di ballo, e a parlare della passione della moglie per la lirica. Benitez ha capito perfettamente ciò che noi non siamo neanche più in grado di dire. E cioè che non siamo — non siamo mai stati — italiani per diritto di sangue, ma sempre per ius soli: per l’appartenenza biunivoca che lega la nostra comunità al nostro territorio, reso unico dall’arte e dalla storia. Ancora oggi lo sperimentiamo: nella percezione del resto del mondo, gli italiani sono identificabili e ammirati, più che per ogni altra cosa, per l’altissima lingua figurativa, per la bellezza civile con la quale abbiamo saputo completare lo splendore naturale del «volto amato della Patria». Mai come oggi questo suolo unico al mondo può, e anzi deve, generare nuovi italiani: integrando nella nostra comunità chi viene a lavorare e a vivere da noi. Che si chiami Rafael Benitez, o che sia un migrante senza nome che arriva (quando ci riesce) sulla spiaggia di Lampedusa. E questo è ciò che Benitez ci ha ricordato con i suoi gesti. Poi le sue parole ci hanno ricordato anche qualcos’altro. E cioè che non siamo capaci di raccontarlo agli altri, quel patrimonio: lui veramente ha detto che non siamo capaci di venderlo. Di fare marketing. Non amo molto questa parola. Perché la quasi totalità della nostra vita è dominata dal denaro, e l’arte e la natura servono invece a rompere questo ferreo dominio. E perché quando un politico parla di «marketing del patrimonio» in genere lo fa per distruggerlo, o per vendere se stesso. E quasi sempre lo fa senza aver mai visto, frequentato, amato, ciò che dice di voler promuovere. Ma Benitez è un’altra cosa: infatti prima ha visto, e poi ha parlato. E ha detto che il patrimonio potrebbe portare lavoro. Ha ragione: potrebbe portare — aggiungo — lavoro dignitoso, e non precario. Diverso dalla schiavitù dei ragazzi che oggi generano reddito privato per i grandi concessionari che cannibalizzano il patrimonio. Il messaggio di Benitez è importante perché mette in relazione diretta due cose sempre separate: il nostro godimento del patrimonio e la capacità di aprirlo agli altri. La costituzione trecentesca di Siena diceva che la città doveva essere bella per «onore, prosperità et accrescimento dei cittadini» e poi anche per «per cagione di diletto et alegreza de’ forestieri». Ecco, la risposta migliore a Benitez non è quella di chiedergli di farci da testimonial. È ritrovare quell’amore per noi stessi e la nostra terra che è l’unica via per poterla poi aprire agli altri.